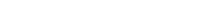KENYA
ETNIA SAMBURU: SOCIETA’ E TRADIZIONI
Nel «deserto di pietre» di Marsabit, nel nord del Kenya, ecco i pastori seminomadi SAMBURU, come pure i TURKANA, i RENDILLE, gli EL MOLO, i BORANA, i GABBRA. Attorno al grande lago Victoria, vivono i dinamici e numerosi LUO. A differenza dei bantu kikuyu e meru, questi popoli sono nilotici, cusciti e nilo-camiti. Altre culture dunque.
SAMBURU
il popolo dalla «schiena dritta»
Viso ovale e altero, corpo robusto e armonioso come una statua greca, dritto come un fuso su una gamba e l’altra sollevata nella tipica posizione dell’airone, la destra appoggiata alla lunga lancia, il guerriero samburu è l’esemplare tipico dei popoli pastori, che disprezzano con orgoglio il «lavoro a schiena curva» dei popoli agricoltori. Anche la danza tradisce tale orgoglio: i guerrieri si divertono saltando, pettoruti e a piedi pari, come canguri, librandosi nell’aria come farfalle, per ricadere sugli stessi centimetri di suolo da cui prendono lo slancio.
ORIGINE
Proprio la farfalla avrebbe dato il nome ai samburu, per quel senso di raffinata armonia, sconfinante nell’effeminatezza, che sprigiona dalla loro vita (*). Per alcuni tale nome deriverebbe da «coloro che hanno il borsellino» (ampur); per altri da «coloro che vanno in guerra» con la sacca dei viveri, per fare razzie o combattere i razziatori.
Un tempo erano conosciuti come burkineji, corruzione di loibor kineji, cioè «possessori di capre bianche». Tra di loro, però, preferiscono chiamarsi lookop, «possessori della terra ». Di fatto occupano un territorio di oltre 20.000 kmq a sud del lago Turkana, costituito dal Distretto Samburu e alcune frange del Distretto di Marsabit.
Da dove siano giunti non si sa. Gli anziani raccontano di provenire da un luogo chiamato Pagaa, probabilmente nell’attuale Sudan, spinti da grave fame e carestia. Una cosa è certa: i samburu sono cugini stretti dei masai, dai quali si sono staccati, non sappiamo quando, formando un gruppo autonomo e omogeneo: entrambi i popoli sono nilo-camiti, nomadi e pastori, parlano la stessa lingua, hanno usi e costumi assai simili. Il termine in-kishu per i samburu significa sia «bestiame» che «persona »: l’identificazione è totale e sacrale, vivendo in profonda simbiosi, sul piano esistenziale e psicologico, soprattutto col bestiame bovino, il cui latte e sangue giocano un ruolo essenziale anche nella simbologia religiosa. Bovini, capre, pecore e qualche dromedario costituiscono la base dell’economia, della sussistenza e del prestigio familiare. Il bestiame fornisce cibo e pelli, che servono per fabbricare oggetti di uso domestico e ricoprire le abitazioni. La quantità, più della qualità, oltre a costituire motivo di orgoglio dell’allevatore, è strategia di sopravvivenza. Le mandrie, divise in piccoli nuclei, vengono dislocate in varie zone del territorio: sull’altopiano e nelle pianure orientali, dove abbondano corsi d’acqua e vegetazione forestale, nella savana delle pianure occidentali e nel semideserto delle pianure centrali ed orientali. Con tale dislocamento i samburu garantiscono la sopravvivenza, in caso di grave crisi, come razzie, epidemie, siccità, di almeno un piccolo nucleo di animali da cui ricominciare.
Ovviamente, il bestiame costituisce la base dell’alimentazione. Ma esso non è visto in funzione della resa di carne, che viene consumata solo raramente, in occasioni di celebrazioni sociali, rituali e familiari. La dieta è quella classica dei popoli nomadi: il saroi, cioè latte unito a sangue.
ORGANIZZAZIONE SOCIALE
Il popolo samburu è diviso in otto grandi famiglie: cinque sono dirette discendenti di altrettanti progenitori; tre sono nate da conflitti e divisioni tribali. All’interno d’ogni clan esistono varie segmentazioni, che rafforzano le relazioni personali, legami di solidarietà e senso di parità. Elemento portante dell’organizzazione sociale e politica sono le classi di età, con funzioni e mansioni specifiche simili al modellato dei masai. Nel sistema samburu tali classi sono sei. Ma poiché ogni classe è racchiusa nel ciclo di circa 15 anni e si entra nella prima all’età di 15-20, le classi più importanti sono quattro, con rari superstiti della quinta e sesta, vegliardi quasi ottuagenari e oltre. La prima classe di età è formata dai giovani iniziati e circoncisi durante lo stesso ciclo di 15 anni: essi sono chiamati moran, cioè guerrieri. La loro funzione, infatti, è militare: hanno il diritto e dovere di difendere il territorio e gli armenti che vi pascolano; di iniziativa propria passano all’attacco per battute di caccia contro animali predatori o per razzie del bestiame alle popolazioni vicine. Non hanno potere decisionale, ma i moran seniori hanno il compito di comunicare la loro esperienza ai coscritti più giovani e ai primi gruppi di iniziati della classe successiva. «Non c’è classe di circoncisi senza il proprio nome» dice un proverbio samburu. Il nome è importante: conferisce identità a individui e gruppi. Per questo tutti gli iniziati di un determinato ciclo ricevono un nome speciale, che li distingue dalle classi precedenti: lkishili sono quelli della classe iniziata nel 1960; lkiroro dal 1975; lmoli dal 1990.
La seconda classe è formata da uomini sposati o in procinto di sposarsi. Essi devono badare alla famiglia e soprattutto accudire al bestiame, la cui crescita procura prosperità e prestigio personale e serve ad avere nuove mogli e figli. La fortuna economica e familiare tornerà utile per acquistare più autorità nel passaggio alla classe successiva.
La terza classe possiede il potere politico e decisionale. È la classe dei padri: i loro figli sono ormai entrati nella prima classe, dei moran, e ne controllano movimenti e attività militari. Le decisioni vengono prese nei consigli degli anziani, cui fanno parte anche i membri delle classi successive. Essi hanno uguale potere politico; ma il prestigio e successo personale possono essere motivo di maggiore ascolto ed efficacia persuasiva. Tali consigli sono locali; ma ci sono occasioni in cui si richiede un consiglio unico per tutto il territorio. La quarta classe, insieme ai superstiti della quinta e sesta, ha funzione «religiosa». I suoi membri sono i depositari della tradizione: rappresentano il legame vivente tra il passato e l’aldilà. Il loro compito specifico è di consulenza e sacerdotale: alcuni riti e cerimonie richiedono la presenza di almeno uno di loro.
Benché in tale sistema organizzativo anzianità e vecchiaia siano altamente rispettate, non si può definire l’ordinamento samburu una gerontocrazia. In tale modello, infatti, il potere e le varie funzioni (militare, economico, politico e religioso) sono distribuiti tra tutti i membri in maniera diffusa e partecipata, sottraendoli al dominio del singolo capo o di un gruppo oligarchico. Le donne, però, sono escluse dalla vita politica e dal meccanismo delle classi di età, dal momento che non sono destinate a restare nel clan.
INIZIAZIONE
Nei primi 15 anni il samburu non conta nulla: è un nkerai (bambino) o layeni (ragazzo-pastorello). Ma con l’iniziazione entra nella maturità. L’iniziato, dopo essere stato rasato e fornito di sandali nuovi, coperto da una pelle di pecora, spalmata dalla madre con grasso e polvere di carbone, viene circonciso davanti alla porta della propria abitazione, con l’assistenza di un padrino. In genere il circoncisore non è un samburu. Il circonciso non deve mostrare paura né lamentarsi per il dolore: sarebbe una vergogna per tutta la famiglia. Dopo la cerimonia il giovane riceve regali, cibo e, dal padrino, arco e frecce. Quindi rimarrà a casa per circa un mese nell’osservanza di restrizioni rituali; quindi comincerà ad andare a caccia di uccelli: un’occupazione di tre mesi chiamata laibartani. Quindi raggiunge gli armenti lontani per dedicarsi al pascolo e alla difesa del bestiame; per una decina d’anni intrecciano atti di coraggio a una vita di vanitosi elegantoni. Ma per diventare un moran il giovane deve passare attraverso tre stadi, con relative cerimonie dette lmugit: sono riti di passaggio obbligatori e punti fermi dell’educazione impartita dagli anziani. Inizia con il lmugit delle frecce (o uccelli), durante il quale viene ucciso un bue: di fronte a sua madre, il giovane giura di non mangiare più carne in presenza di donne sposate. Solo da questo momento diventa moran e può dipingersi il corpo con l’ocra rossa.
Segue il lmugit del nome, quando il giovane ha circa 20 anni. Anche questo rito è accompagnato dal sacrificio di un bue, ucciso per soffocamento: esso non deve cadere a terra, ma tenuto sollevato dai giovani per i quali la cerimonia è celebrata. Il bue dovrà essere mangiato interamente e le ossa bruciate. Il lmugit del toro, in cui viene ucciso un altro bue, chiude praticamente il periodo del «moranato»: il giovane è pronto per il matrimonio e passa nella seconda classe di età.
IL MATRIMONIO
Il cerimoniale del matrimonio è complesso e suggestivo. Le trattative con la famiglia della sposa sono condotte dall’interessato, col sostegno del padre; ma ogni anziano della parentela paterna o materna può mettere il veto sulla ragazza scelta, minacciando di maledire i futuri figli. Oltre agli otto buoi da consegnare al suocero, lo sposo deve procurare vari regali per la sposa (due pelli di capra, due orecchini di rame, un recipiente per il latte, una pecora) e vari capi di bestiame per parenti e affini e da sacrificare per la festa. La sposa dovrà procurarsi un grembiule speciale, orecchini, un pezzo di pelle di leone da legarsi alla gamba, perline, sandali, un bastone di pianta detta nkoita.
Per la data delle nozze, la nuova luna è la più propizia e i giorni pari i più adatti. Quel giorno, di primo mattino, la promessa sposa viene circoncisa (clitoridectomia). Tre quarti d’ora dopo giunge lo sposo, accompagnato dal compare e da altri che sospingono un bue, una vacca ed una pecora. La madre della sposa toglie i paletti che ostruiscono l’entrata della capanna ed il bue viene fatto entrare ed è ucciso. Con tale sacrificio il matrimonio è validamente ratificato, anche se la cerimonia è appena iniziata. Seguono riti complicati per la divisione della carne del bue; quindi gli anziani avviano una litania di benedizioni sul padre della sposa, deponendo burro sulla sua testa.
Per tutto il giorno si compiono altri riti e il mattino la sposa deve recarsi a piedi fino al villaggio dello sposo. Il viaggio, spesso lungo e penoso per la donna appena circoncisa, termina alla manyatta (capanna) dello sposo; vi entra passando tra due file di anziani che benedicono la nuova coppia. Nella nuova capanna essa accende il fuoco nuovo, che deve scaturire da due bastoncini sfregati: il fuoco non dovrà mai spegnersi finché la nuova famiglia si trasferirà altrove.
MONDO DEL SACRO
Fulcro delle credenze religiose, attorno a cui ruotano preghiere, sacrifici e la stessa vita, è Nkai, Dio buono e severo contemporaneamente. Al di sotto di lui c’è una serie di spiriti custodi, posseduti da ogni cosa e persona.
Il termine nkai serve per indicare anche il cielo e la pioggia; ma il concetto che i samburu hanno della divinità è molto chiaro: Dio è unico, onnipotente, onnipresente, provvido, ecc. In generale, gli attributi lo descrivono come essere maschile; ma alcuni lo descrivono come ente femminile, quando, per esempio, lo si prega perché sorregga l’uomo, come una mamma sostiene i suoi bimbi. Anche se gli attribuiscono forme antropomorfiche, i samburu rifuggono dal compararlo agli uomini: Nkai è Nkai, dicono. Benché Dio sia dappertutto, alcuni luoghi, densi di fascino e meraviglia, sono ritenuti privilegiati dalla presenza divina, come i monti Ng’iro, Marsabit e Kulal, oppure grosse piante, cave, sorgenti d’acqua. Luoghi sacri in cui si svolgono i riti più importanti della vita. Oltre alle preghiere quotidiane in cui, in modo assai spontaneo, si invoca Dio per le necessità dell’etnia, clan, famiglia o individuo, i samburu esprimono il loro culto mediante il sacrificio. Un tempo avevano il lasar, sacrificio di offerta. Oggi, il sorio, sacrificio di ringraziamento, è l’atto di culto fondamentale: ricorre due volte all’anno. Lo si celebra di sera in ogni gruppo di capanne e consiste nell’offerta di una pecora nera, grassa, non ancora incinta. La carne viene arrostita e mangiata: la parte destra dagli uomini e la sinistra dalle donne. Il sangue, mescolato con l’interno dello stomaco, viene spalmato sulle capanne e sugli animali. Contrapposto a Dio buono, i samburu credono in uno spirito maligno chiamato Milika, pressappoco il nostro demonio.
Al pari di altre etnie africane, anche i samburu hanno la figura del mago-guaritore (loiboni), a cui si ricorre in caso di malattia inguaribile, sterilità, peste del bestiame, prima di affrontare il nemico… È retribuito con buoi e montoni. I suoi strumenti sono sassolini, cianfrusaglie e radici contenute in zucchette. È un personaggio temuto da tutti e di cui non si parla volentieri. Dal canto suo, il mago-guaritore non ama mostrarsi in giro. Egli trasmette il suo mestiere al figlio più abile, insegnandogli i segreti di erbe e veleni. Quando muore viene sepolto sotto un mucchio di sassi. Un altro importante personaggio è il laidetidetani, indovino o sognatore. Suo compito è interpretare i sogni, conoscere le stelle, prevedere l’arrivo della pioggia. Il lais, invece, è un personaggio dotato del potere di ritrovare cose perdute, portare fortuna o iella. Da costui i samburu stanno volentieri alla larga.
LA MORTE
Anche la morte ha il suo cerimoniale. In genere i morti non sono seppelliti, eccetto i personaggi molto anziani e rinomati e i bimbi di pochi mesi; questi sono sepolti presso il fuoco nella capanna, che viene poi abbandonata. Per questo l’anziano samburu, quando sente la morte vicina, prega così: «Dio, fammi un vero lookop: non permettere che l’erba mi mangi». Chiede, cioè, di morire nel suo clan e non lontano dal villaggio; di avere una sepoltura onorevole e una tomba riconoscibile, non coperta dall’anonimato della savana; di essere sepolto con la faccia rivolta alla montagna sacra, sede di Dio. In tal caso, il morto, rasato, viene adagiato sulla pelle su cui dormiva e sistemato in modo che la sua faccia sia rivolta verso la montagna. La gente deporrà rami intorno dicendo: «Dormi da solo!». Il luogo verrà ricordato per un po’ di tempo; chiunque passerà accanto alla tomba vi getterà un ramo verde.
(*) Cfr. anche: Achille Da Ros – Virgilio Pante – Egidio Pedenzini, Proverbi Samburu, Emi, Bologna (in samburu, inglese e italiano).
DA: http://www.rivistamissioniconsolata.it/cerca.php?azione=det&id=1058